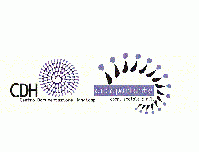di Amedeo Gagliardi/ Erano trascorsi 17 giorni da quando mi ero consegnato, 17 giorni nei quali non avevo più potuto sentire mia figlia Elisabetta, di 11 anni. Venni chiamato dalla guardiola da uno degli assistenti e mi venne ordinato di entrare nella piccola stanza che funge da cabina telefonica. Così feci. Al telefono una voce femminile con accento romagnolo mi pose domande su mia figlia, alle quali risposi, senza però memorizzare il nome della signora; solo dopo aver riagganciato la cornetta realizzai di non aver chiesto le sue generalità e chiesi informazioni all’appuntato; informazioni che non arrivarono.
Vissi nell’inquietudine per ulteriori 7 interminabili giorni, nel terrore che fossero potuti intervenire i servizi sociali, eventualità che avevo scongiurato affidandola in ottime mani. Fin quando, finalmente, venni autorizzato alle chiamate verso mia figlia, al nuovo numero che mi era stato fornito dal mio avvocato. Mi affrettai a chiamare col nodo in gola. La dolce Eli non rispondeva. Riprovai ad oltranza. Ogni volta rimettendomi in fila davanti alla cabina e dovendo fare anche i conti con coloro che entravano ed uscivano per prendere o mettere cibo nel congelatore, che, in barba alla privacy, è posto nella stessa stanza. Niente da fare. Mia figlia non rispondeva. Allora chiamai il mio avvocato per fare avvisare chi potesse dirle che la stavo chiamando, bruciando una delle due telefonate dirette verso lo stesso. Trascorse un’altra ora, interminabile in quel contesto, finalmente Eli rispose ed io esplosi in un urlo disordinato, strozzato, incontenibile e lunghissimo, misto a singhiozzo, lacrime, gioia ed impotenza. un’esplosione lunga 24 giorni di enorme sofferenza.
Dalla bocca mi fuoriuscì una voce che non mi ero mai sentito addosso e che spaventò anche me; una voce soffocata e sovrumana, che sembrava provenire dalle profondità più recondite della mia ugola e che trascinava con sé tutto il dolore e tutta l’angoscia accumulata, come un fiume che straripa inghiottendo tutto ciò che investe.
Il tempo messo a disposizione dall’amministrazione carceraria è di soli 10 minuti. ln quei 10 minuti avrei voluto comunicarle tutto, ma proprio tutto. Tutta quella angoscia che avevo vissuto in quei 24 giorni. I sentimenti che provavo per lei, sapere di lei, dei risultati scolastici e di quelli sportivi da lei ottenuti. Troppo pochi quei 10 minuti, gli ultimi 30 secondi dei quali scanditi da una voce preregistrata che ne comunica lo scadere, fornendo anche a lei questa crudele informazione. Ho dovuto imparare a gestire quel tempo, pur in assenza di un orologio che mi possa supportare, percependone immaginariamente la quantità, anche e soprattutto di quegli ultimi 30 secondi, nei quali devo governare, oltre ai saluti dì commiato, le mie emozioni, ma soprattutto quelle di Eli, che non avrebbe voluto concludere la telefonata e che, curiosa e quasi divertita nella sua ingenuità infantile, avrebbe voluto conoscere il finale del simpatico racconto che io, suo padre le stavo fornendo.
Quella troncatura improvvisa della conversazione, percepita come una ingiustificabile tagliola, quel distacco repentino al quale ancora oggi non so dare una spiegazione logica e che né mia figlia né io riusciamo ad accettare, mi procurò tanta frustrazione e mi sentii ancora più impotente di quanto già io fossi prima di quella telefonata. Eppure nella mia vita sono stato conduttore televisivo, speaker radiofonico e voce per jingle o per spot radiotelevisivi (guarda caso da 30 secondi). Oltre a questo ero stato amministratore di società per azioni e formatore di corsi, uno tra gli altri proprio sul time management, quindi conosco bene il valore del tempo eppure quei 10 minuti e, soprattutto, quei 30 secondi mi sembrarono davvero troppo pochi per concretizzare le mie intenzioni e, ciò che è peggio, per soddisfare i desideri di mia figlia ora ritrovata. Avevo già vissuto questa angoscia quando mi era stata rapita appena nata dalla di lei madre e ne avevo perso le tracce per 6 mesi ed ancor prima quando avevo subito l’allontanamento del figlio avuto dalla mia prima moglie. Ne conosco il dolore. ne conosco anche i sintomi e le conseguenze di quella che viene definita “alienazione genitoriale”.
Avendo a mia disposizione 4 telefonate alla settimana (già una grande concessione, ma solo perché mia figlia è minore) da 10 minuti ciascuna, pensai di provare a richiamare sfruttandone un’altra consecutiva, ma venni così a scoprire che non se ne possono fare più di una al giorno. Avvilito, mentalmente spossato, tornai in cella, sperando di non aver deluso le aspettative di mia figlia, che forse poteva aver pensato si potesse trattare della classica interruzione di linea e che, come sempre, il suo papà l’avrebbe prontamente richiamata. Questo pensiero mi divorava. La consapevolezza dell’incomprensione di coloro che vivono una vita normale fuori è un fardello con cui sto imparando a convivere.
Il giorno successivo e quell’altro ancora mia figlia non rispose al telefono ed io temetti che le mie immaginazioni stessero trovando conferma. In realtà non era cosi, ma non potevo ancora sapere che mia figlia era semplicemente impossibilitata a rispondere perché ospite a casa dì un’amichetta, forse per il pudore di doversi giustificare di avere un papà assente per un preciso ed imbarazzante motivo.
In carcere, però, sono queste le sofferenze peggiori, quelle cioè determinate dall’ignoto di ciò che accade fuori e dall’assenza di informazioni temporalmente ed univocamente condivise. Ciò che accade alle persone amate, a te stesso, per le incombenze che hai lasciato obbligatoriamente in sospeso e che arrovellano la mente in modo devastante. È impercepibile infatti, per coloro che vivono una vita normale fuori, l’impotenza che opprime un detenuto rispetto alle sue affettività ed alle sue consuetudini.
Dopo 50 giorni venni finalmente autorizzato alle video chiamate con mia figlia. Arrivò il giorno prenotato e la persona adulta preposta alla risposta non cliccò il link; andai in panico e mi scappò qualche lacrima; l’agente penitenziario, una donna, se ne accorse ed avvisò l’ispettore di sezione, il quale si prese a cuore la situazione, provvide a chiamare la signora e scoprì che la bambina non voleva perdere l’ultima ora di lezione, l’ora di educazione fisica, alla quale, per motivi agonistici, era stata lungamente assente. L’ispettore, allora, in deroga al regolamento, predispose di far effettuare la video chiamata nel pomeriggio. La mia felicità era infinita e il tutto avvenne piacevolmente. Mia figlia manifestò grande euforia. Il dialogo fu pregante e gradevole, ricco di risate; ma al termine dell’ora riservata, purtroppo, l’assistente entrò nella cabina e, poggiandomi una mano sulla spalla, mi avvertì che l’ora era terminata. In quel momento mia figlia si incupì e si lamentò crucciosa per il fatto che la conversazione dovesse interrompersi. L’allontanamento fisico dalla cabina da parte di mia figlia fu una scena straziante, che lasciò interdetti sia me sia mia figlia una volta staccato il collegamento. Scoppiai in lacrime. La video chiamata successiva non poté aver luogo in orario pomeridiano. Mia figlia, uscendo da scuola alle 14, non arriva a casa, ancor digiuna, prima delle 14.15. Alle 14.30 l’agente addetto alle video chiamate deve staccare. Mi chiedo, quindi, dato che fino al compimento della maggiore età tutti i minori vanno a scuola al mattino, quale sia la ragione che impedisce l’organizzazione delle video chiamate anche in orari pomeridiani?